di Rebecca Rovoletto·- 1° maggio 2018
Mi sento al sicuro nel taxi di Gonzalo, posso abbandonare l’allerta
del viaggio, la fatica della sua preparazione, i perché ho risposto a un
invito arrivato da così lontano. Ora sono qui. Dal finestrino mi
incanta una luna storta: sta calando all’ingiù, gobba a terra e sorriso
al cielo. Del resto, qui anche i perché usano un punto interrogativo
sottosopra, messo lì prima ancora di formulare la domanda. Mi appendo a
quel glifo e prende corpo la que sabe, colei che sa: dondola, donna, fiuta, accendi i pori.
All’inizio dell’anno, l’EZLN lancia una convocatoria, una chiamata. Dall’avvio della Otra Campaña gli zapatisti hanno creato molte aperture internazionali e i loro inviti sono stati sempre più frequenti: l’Escuelita, il CompArte, il ConCiencias por la Humanidad.
Artisti, intellettuali, scienziati, rappresentanti della società civile
e militanti hanno risposto alle loro iniziative, per discutere
orizzonti.
Questa convocatoria è però diversa dal solito. È concepita
femmina, voluta e organizzata dalle donne zapatiste per le donne di
tutto il mondo. Gli uomini non sono invitati, non importa se buoni o
cattivi. C’è bisogno di un momento solo per noi, lontano dalle critiche o
dalle compiacenze di uno sguardo maschile. Libere di essere ciò che
siamo e di fare ciò che amiamo fare, nel nostro modo personale di
divaricare crepe nei muri del sistema capitalista e patriarcale. “…in
tutto il mondo ci assassinano. E agli assassini che sempre sono sistema
con volto da maschio non importa nulla se siamo ammazzate. Quindi, se
sei una donna che lotta, che non è d’accordo con quello che ci fanno
come donne che siamo, se non hai paura, se hai paura ma la controlli, ti
invitiamo a incontrarci e parlarci e ascoltarci come donne che siamo.” Ci chiedono di portare lì, al Caracol
IV di Morelia nel sudest messicano, tutto quello che desideriamo
condividere come donne impegnate sui più diversi fronti dell’attivismo
sociale e politico per la difesa della natura, delle risorse primarie,
dei diritti inalienabili, delle minoranze, delle culture originarie,
della vita. E siccome il mondo va descritto nella sua complessità, senza
lesinare parole, lo titolano Primo Incontro Internazionale Politico, Artistico, Sportivo e Culturale delle Donne che Lottano.
Nello zapatismo vivente nel Chiapas niente di ciò che credi logico o
scontato è così. Puoi avvicinarti solo se ti asterrai dal comprimerlo
dentro cornici codificate. Perché questi indios contadini ne sanno
sempre una più di te e ti ribaltano come quel punto interrogativo. E
quando ti chiedono di guardare e ascoltare ti stanno dicendo di cavare
via le croste al cervello, di esporre la polpa. E devi anche sapere che
solo la millesima parte di ciò che assaggerai potrà essere raccontata,
perché senza anime eccitate dai corpi non si comprendono diversità,
linguaggi, figurazioni.
Dalle mail organizzative dell’equipe de apojo so che si
stanno registrando adesioni da ogni parte del globo, tanto che devono
metterle in fila alfabetica: Andorra, Argentina, Australia, Bolivia,
Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Danimarca, Ecuador,
El Salvador, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Guatemala, Honduras,
Inghilterra, Italia, Nazione Mapuche, Nazione Cree e Ojibwa, Nazione
Navajo, Nicaragua, Paesi Baschi, Paraguay, Perù, Porto Rico, Repubblica
Dominicana, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Tanzania, Uruguay,
Venezuela e 27 stati del Messico. Parlano di oltre seicento richieste di
partecipazione attiva e ci anticipano alcuni dei temi e delle proposte
che sono arrivate: 202, un’enormità.
Il 7 marzo mi sveglia il caffè a San Cristòbal, tra le montagne della Sierra Madre a 2.200 metri, nella casa azùl di Francesca, Fabio e la piccola Emma. Si parte dal CIDECI alle 13:30, ora zapatista, dentro un Lacandonia Tour, un camiòn
blu che viaggia a passo d’uomo. Dicono che la nostra destinazione
finale dista circa duecento chilometri zapatisti, in direzione circa
Palènque. Fuori boschi di conifere e qualche ragazzino scalzo che corre a
salutare con la mano. A bordo spiccano in risate quattro italiane,
delle pochissime che troverò all’incontro. Da questo momento Rosella,
Serena, Daniela e Nancy saranno le mie compagne di pannocchie bollite e tamales,
di discussioni e stupore. Ma nello zaino ci ho ficcato strette un bel
po’ di altre amiche, Arianna, Teresa, Desi, Lisa, Marina, Moira e poi
Elena, Giulia, Laura… mi si attacca ai vestiti anche Raffaella. Quale
magico filo di ragno ti ha portata a seguirmi qui, Raffaella?
Attraversiamo la regione detta “tzotz-choj” (pipistrello-giaguaro),
abitata dai popoli maya tzeltal, tzotzil e tojolabales, tra i principali
partecipanti alla sollevazione in armi del ‘94.
Come molte altre in
Chiapas e in Messico, questa zona è stata ed è teatro di lotte contadine
per preservare terra, diritti e culture native. Quella zapatista ha
preso la forma dei governi autonomi (Municipi e JBG, Giunte di Buon
Governo) nella cui costruzione e partecipazione l’apporto delle donne
continua ad essere cruciale.
E cruciale, qui, è anche la poesia che impregna ogni cosa, il nucleo profondo di questi popoli. Caracol IV, Torbellino de Nuestra Palabra – Turbine della Nostra Parola – quartier generale della JBG Corazón del Arcoiris de la Esperanza – Cuore dell’Arcobaleno della Speranza. È qui che approda, dopo sette ore di buche e dossi, il nostro eroico Lacandonia Tour. BIENVENIDAS MUJERES DEL MUNDO
Il piazzale sterrato è un girone di zaini, borse, sporte, fagotti,
trolley e, attaccato a ciascun bagaglio, c’è una donna da sola, con le
amiche, con le altre donne della famiglia, con un bimbo al collo e uno
per mano, con l’anziana nonna che si aiuta con un carrellino, con la
fidanzata, con le compagne di collettivo. Di ogni età, colore, etnia,
nazionalità, lingua, dialetto. Dappertutto piccole donne col
passamontagna ci circondano: le nostre ospiti, le donne zapatiste dei
Cinque Caracoles. A vigilare e coordinare le miliziane in divisa
dell’EZLN “custodi dell’autonomia e di madre terra”. Cosa avranno
provato nel vederci arrivare? Nel vedere che quel loro progetto sognato,
discusso e organizzato da sole in un buco di mondo è lì sotto ai loro
occhi gentili, vero e vociante, ed è enorme? “Perché è dura quando
ci dicono che ne arrivano cinquecento ma che si è perso uno zero per
strada e ne arrivano cinquemila e più” **
Despierta, mujeres del mundo. Buenas dìas. 8 marzo 2018 ore
5:52. Due accordi di chitarra nel primo accenno d’alba chiamano le
donne. È l’inizio di ciò che non ti aspetti, che ti sguscia fuori dal
sacco a pelo e ti sguscia dal mondo che hai vissuto sinora per
incontrarne moltitudini. Ma non sono mondi altri, ce li hai tutti dentro
e mai come ora ti sei sentita così profondamente a casa. Buongiorno
alba del giorno che è il giorno. Buongiorno angolo sperduto di terra che
hai fatto fiorire tutto questo.
Il primo è il giorno delle donne zapatiste. Si presentano come donne
combattenti nella difficile quotidianità di chi ha scelto di vivere la
libertà, di realizzare l’autonomia, di imprimere una trasformazione
sociale e politica che non ha eguali. Ci regalano la genealogia della
loro lotta, il loro sguardo sul mondo e la loro visione di ciò che sarà.
Una narrazione fatta di letture, poesie corali, opere teatrali, tornei
sportivi, coreografie, musica e canti e danze. Ma si raccontano anche
standoci intorno, cucinando per noi, proteggendoci e prendendosi cura di
ogni cosa. I loro occhi ci parlano di grazia dal passamontagna, i loro
gesti tranquilli e sicuri ci danno il passo e la misura di un tempo
umanissimo. La loro attenzione, ironica e curiosa, ci insegna
l’accoglienza e l’affettività. Finalmente ti conosco di persona, Difesa
Zapatista, piccola e tenace bambina che ogni giorno giochi la difficile
partita che ti vede a sera ancora viva e libera.
Con questo loro primo giorno imprimono il senso tangibile del
sentimento collettivo dell’essere comunità. Lorena, la sciamana maya, ha
predisposto un cerchio di fuoco. È un battesimo. Le parole di apertura
ci fondono, spazzano via i nostri brillanti ego e inutili dispute,
diventiamo un chingo. “E vediamo, ad esempio quegli alberi
laggiù che voi chiamate ‘foresta’ e noi chiamiamo ‘montagna’. E sappiamo
che in quella foresta, in quella montagna, ci sono molti alberi
diversi. Bene, siamo qui come una foresta o come un monte. Siamo tutte
donne… una foresta di donne. Possiamo scegliere cosa fare durante questo
incontro. Possiamo scegliere di fare a gara… o possiamo parlare e
ascoltare con rispetto. Possiamo fare a gara tra di noi e alla fine,
quando torneremo ai nostri mondi, scoprire che nessuna ha vinto, oppure
decidiamo di combattere insieme, ciascuna con le proprie differenze. Qui
siete tutte benvenute e vi ascolteremo, guarderemo e parleremo con
rispetto, compagne e sorelle, noi non giudichiamo nessuno” *
Tutte, senza pudore e tabù, senza dogmi e pregiudizi, ci sentiamo
libere di sdoganare quella sensazione inconfondibile di sacra
selvatichezza che ci reintegra nella nostra identità umana e femminile.
Sì, si è prodotta una magia, una magia pienamente politica, inutile
cercare di parafrasare. Tutte quante, occidentali o indigene, di
campagna o di città, femministe o meno, intellettuali, fotografe,
attiviste politiche e sociali, sciamane, cantadoras,
simpatizzanti per qualche partito, suonatrici di tamburi, giornaliste,
lesbiche e transgender, danzatrici, esponenti di associazioni e
movimenti, artigiane… tutte tocchiamo qualcosa cui dopo due mesi ancora
fatichiamo a dare pressappoco un nome, perché dobbiamo inventarcelo un
nome per qualcosa che nessuna di noi ha mai visto. Una politica
‘salvatica’.
Escono i tabelloni coi programmi di venerdì e sabato, organizzati in mesas, plàticas e talleres ma
anche laboratori improvvisati, mostre ed esposizioni, installazioni,
attività di ogni natura brulicanti in ogni anfratto. Lingue ancestrali
si rincorrono tra le tende, pentoloni fumano di continuo, musica
dappertutto. Se con le prime luci dell’alba ci rendiamo conto di quante
siamo, alla fine un totale che sfiora le diecimila donne, con i
tabelloni capiamo chi siamo e che siamo tutte qui, con tutti i nostri
femminili e femminismi, todas aquì estamos. Torbellino de nuestra palabra.
Il turbine delle nostre parole di donne irrompe per tre giorni eterni
in mezzo alla Selva. Parole solo in parte verbali. Il femminile, quando
ritrova integrità, parla col corpo, con le ovaie, con gli occhi, con
modulazioni liquide, con flussi di braccia, con ritmi vascolari. Con
questi suoi strumenti naturali il femminile parla di politica. Ne parla e
la fa, la politica, cuocendo e nutrendo pensieri, idee, iniziative,
azioni poderose.
Giro, ascolto, guardo, partecipo e mi rendo conto che quando, nel mio intervento, dentro un comedor
incandescente, ho parlato della colonizzazione dei territori ad opera
dei megaprogetti e della colonizzazione della psiche femminile che si
infiltra nei movimenti, non ho detto nulla di strano. Ovunque sento
rimbalzare la mia stessa riflessione: la monocultura patriarcale ha
desertificato ampi territori della psiche femminile, una sorta di
land-grabbing ci riduce a pensare, sentire, agire nelle lotte, come
donne, secondo quello stesso modello che vogliamo contrastare. Ma qui
non sta succedendo. Quel marchio che le zapatiste ci hanno impresso
diventa un antidoto e sperimentiamo come si può stare tra di noi facendo
politica in modo nuovo, caldo.
Cerchi nascono e respirano con le madri dei 43 studenti di Ayotzinapa
spariti tre anni e mezzo fa. Spirali di gonne abbracciano le parole
delle migranti transfrontaliere. Danze sincroniche circondano le storie
di donne vittime di stupro. Mani a farfalla sui racconti di lotta dei
popoli Mapuche. Fili di lana intessono le persecuzioni delle curanderas guatemalteche.
Una Batucada
colombiana ritma le segregazioni razziste nei popoli nativi e
afro-latinoamericani. Corse di bimbi intersecano il dramma della
Palestina. L’aroma di cannella accompagna il saccheggio dei territori. Rebozos
sgargianti e muti sul videomessaggio dal Rojava. Sincretismi in cui
grazia, anima, cura, spiritualità si fanno strumenti di politica viva.
Non c’è frontiera tra uno spazio interiore e uno esterno, tra uno spazio
personale e uno politico, tra umanità e natura, tra intelletto e corpo.
Tutto co-è, tutto è necessario che sia.
Dal palco cambia la musica. Tolgono l’elettricità, si fa buio pesto e duemila candele zapatiste vengono accese: “Questa
piccola luce è per te. Prendila, sorella e compagna. Quando ti senti
sola. Quando hai paura. Quando senti che la lotta è molto dura, o che lo
è la vita, riportala al tuo cuore, ai tuoi pensieri, alle tue viscere. E
non la cedere, compagna e sorella. Portala alle scomparse, alle
assassinate, alle detenute, alle violentate, alle picchiate, alle
molestate, alle violate in tutti i modi, alle migranti, alle sfruttate,
alle morte. Prendila e dì a ciascuna di loro che non è sola, che
combatterai per lei… Prendila e trasformala in rabbia, in coraggio, in
fermezza. Prendila e unisciti ad altre luci. Prendila e, forse, poi ti
verrà da pensare che non ci sarà né verità, né giustizia, né libertà nel
sistema capitalista patriarcale. Allora forse ci rivedremo per dare
fuoco al sistema. E diremo: ‘Bene, ora sì cominciamo a costruire il
mondo che meritiamo e che necessitiamo’. Perché quello di cui c’è
bisogno è che mai più nessuna donna al mondo, di qualsiasi colore sia,
peso, età, lingua, cultura, abbia paura.” ** Todas aquì estamos.
*dal discorso di apertura, 8 marzo 2018, Capitana Insurgente Erika
**dal discorso di chiusura, 10 marzo 2018, Compa Alejandra
Foto di Maria M. Caire
tratto da Comitato Chiapas Maribel
venerdì 4 maggio 2018
giovedì 26 aprile 2018
Le insurrezioni delle donne
Sono le donne che di fronte a spazi urbani sempre più esanimi e atomizzati stanno rinvigorendo la socialità delle città. Sono per lo più le donne a creare, nel Nord come nel Sud del mondo, un nuova economia urbana di sussistenza attraverso cucine popolari, orti e giardini comunitari, mercatini e assemblee di quartiere, arte di strada, tutte forme embrionali di autogoverno. Sono le donne che in risposta alla precarizzazione del lavoro e alla crisi dei salari si sono appropriate delle strade e le hanno fatte diventare commons. Tuttavia, secondo Silvia Federici, non si tratta soltanto di rendere più visibile cosa oggi le donne fanno per resistere e creare un mondo nuovo ma prima di tutto come lo fanno, a cominciare dai modi con cui trasformano l’arte di strada: «È opportuno pensare alla lotta che le donne e i movimenti popolari stanno facendo nei quartieri poveri in tutto il mondo come a una escuelita – scrive Silvia Federici – , dove gli artisti, gli attivisti, gli educatori possono imparare non solo a “de-professionalizzasi” ma a coltivare un diverso tipo di creatività rispetto a quella solitamente associata all’espressione artistica. Questa è la creatività che si genera quando modifichiamo i nostri rapporti con gli altri, scoprendo nel potere della cooperazione il coraggio di resistere alle forze che opprimono la nostra vita…»
 |
| Mondeggi bene comune |
Produrre il comune nella città*
Immagini di donne con le braccia estese a racchiudere case e piazze, o a stringere i propri corpi in reciproci abbracci, o a intrecciare fili intorno a se stesse e alle città, possono evocare una società matriarcale idealizzata. Ma questo mondo femminile e comunitario, alla cui rappresentazione il pittore messicano Rodolfo Morales ha dedicato la sua opera, è meno utopica di quanto si possa immaginare[1].
 |
| “Unidad perpetua”, 1987 (Rodolfo Morales) |
Già nel 1999, riflettendo su come le città siano storicamente dipese dall’entroterra per la loro sopravvivenza, Maria Mies osservava che in tutto il Terzo mondo è cresciuta un’economia urbana di sussistenza praticata nei centri urbani e organizzata principalmente dalle donne. Essa garantisce non solo le necessità materiali della vita ma anche la coesione sociale[3]. Mies scriveva che se aggiungiamo alla produzione alimentare diretta tutte le altre varie forme di lavoro di sussistenza – la preparazione del cibo, gli scambi di alimenti, i servizi, l’aiutare gli altri, l’andare a prendere e portare l’acqua – è evidente che la sopravvivenza della maggioranza della persone in queste città dipende dal lavoro di sussistenza delle donne[4].
L’economia di sussistenza urbana descritta da Mies ha continuato a espandersi in questi anni, alimentata in gran parte dalle continue espulsioni dalla terra delle comunità rurali. Di fronte a una crisi economica permanente, nelle periferie delle mega-città sparse in tutta l’Africa, l’Asia e l’America Latina, in aree occupate con l’azione collettiva, le donne stanno creando una nuova economia politica, basata su forme cooperative di riproduzione sociale e, nel corso di questo processo, affermano il loro “diritto alla città”[5] creando nuove basi per resistere e per avanzare le proprie rivendicazioni. Grazie ai loro comedores populares, ai merenderos, ai giardini urbani e alle assemblee di quartiere (barriales), le periferie urbane che hanno portato Mike Davis a parlare di un “pianeta degli slum” si possono ri-immaginare come un pianeta di iniziative e strutture comunitarie, in cui emerge un “contro-potere” che consente ai residenti non solo di sopravvivere ma di sviluppare forme embrionali di autogoverno.
In base a queste esperienze, credo che al “punto zero della ri-produzione”[6], dove svanisce l’illusione che lo Stato e il capitale possano sostenere le nostre vite, la lotta per la sopravvivenza diventi una forza trasformatrice. Riecheggiando un argomento sostenuto dall’attivista e teorico uruguaiano Raúl Zibechi, esistono oggi migliaia di quartieri, ai margini del sistema statale, dove le donne assicurano la continuità della vita quotidiana. In essi si istituiscono nuove relazioni sociali, che procurano servizi essenziali e cambiano il modo in cui la riproduzione è organizzata – e sono le donne le protagoniste di questo processo[7].
Altrettanto importante è che le donne, per contrastare gli effetti dei programmi di austerità imposti alle loro comunità dalla liberalizzazione economica, a partire dalla metà degli anni Settanta, abbiano messo in comune molte attività riproduttive come fare la spesa, cucinare e seminare.
Un esempio particolare è il caso del Cile dopo il colpo di Stato militare del 1973, quando negli insediamenti proletari urbani paralizzati dalla paura e contemporaneamente sottoposti a un brutale programma di austerità, le donne si sono fatte avanti, e unendo le loro risorse e il loro lavoro hanno iniziato a fare la spesa insieme e poi a cucinare insieme, in gruppi di venti o più nei quartieri. Queste iniziative, nate per pura necessità, hanno tuttavia prodotto molto di più che il mero aumento delle risorse economiche. L’atto stesso di riunirsi e rifiutare l’isolamento a cui il regime di Pinochet costringeva la popolazione, ha cambiato la vita delle donne, dando loro maggiore fiducia in se stesse, e ha rotto la paralisi indotta dalla strategia governativa del terrore. Ha anche riattivato la circolazione di informazioni e conoscenze necessarie per sopravvivere e resistere, e ha trasformato il concetto stesso di cosa sia una buona madre e una buona moglie che, sempre di più, ha voluto dire uscire da casa e lottare[9]. Di conseguenza, il lavoro riproduttivo ha smesso di essere un’attività puramente domestica. Con le grandi pentole per cucinare è sceso in strada anche il lavoro domestico, che è entrato nello spazio pubblico acquistando una dimensione politica anche agli occhi delle autorità, che dopo qualche tempo hanno cominciato a vedere nell’organizzazione delle cucine popolari un’attività sovversiva e una minaccia per il potere.
 |
| Prinzessinnengärten, orto urbano di Berlino (Ph Vanessa Scarpa) |
Anche in Bolivia, di fronte all’impoverimento delle loro comunità, le donne hanno portato il lavoro riproduttivo fuori dalle case. Di conseguenza, come afferma Maria Galindo dell’organizzazione Mujeres Creando[11], l’isolamento tipico del lavoro domestico è stato spezzato e si è formata una cultura di resistenza. Galindo parla della lotta delle donne per la sopravvivenza come di una rottura con la sfera della casa e della famiglia. E sottolinea come l’immagine della donna chiusa in casa appartenga ormai al passato, perché in risposta alla precarizzazione del lavoro e alla crisi dei salari maschi le donne si sono appropriate delle strade e le hanno trasformate in mezzi di sussistenza, in veri e propri commons dove trascorrono la maggior parte del tempo, e dove i figli possono fare i compiti mentre aiutano le madri con il loro lavoro[12].
Il lavoro domestico a pagamento ha contribuito alla ridefinizione dello spazio urbano. Visto in un primo momento come luogo pericoloso, dove le lavoratrici domestiche, in gran parte emigranti, potevano essere fermate dalla polizia, esser trovate senza documenti e subire abusi, lo spazio pubblico è diventato un luogo di autonomia e di incontri, un luogo dove rompere l’isolamento del lavoro e guadagnare visibilità per le proprie rivendicazioni, e raggiungere un pubblico più ampio. Le lavoratrici filippine hanno aperto la strada, cercando spazi sociali – parchi, chiese, centri commerciali – in cui riunirsi nei giorni di riposo o di domenica. In alcune città (per esempio Hong Kong) sono scese in piazza con spettacoli pubblici settimanali, con canti e balli focalizzati sui problemi inerenti alla loro vita e alle loro esperienze lavorative. Avere una presenza sul territorio, occupare il territorio – la strada, il marciapiede, il parco – è una pratica che è stata dettata non solo dalla necessità di rompere l’isolamento, ma dalla realizzazione che per combattere le restrizioni poste dalle politiche sull’immigrazione è essenziale diventare visibili e far conoscere la propria storia. Secondo Priscilla Gonzalez, per molti anni coordinatrice di Domestic Workers United – una delle principali organizzazioni di lavoratrici domestiche negli Stati Uniti – questo si è rivelato una forma di lotta molto efficace[13]. Facendo conoscere le loro storie, le lavoratrici domestiche immigrate non solo hanno condiviso le loro esperienze, ma hanno anche sviluppato una maggiore consapevolezza della propria condizione come donne e una comprensione più ampia delle conseguenze della globalizzazione per le loro comunità.
L’arte è stata un elemento chiave nella lotta. L’arte abbellisce gli spazi urbani in cui le persone vivono e lavorano dando valore e dignità alla nostra vita. Mostra i successi della comunità, mantiene viva la memoria di coloro che sono morti o imprigionati. I murales, il teatro di strada, la produzione di manifesti, spillette, volantini, magliette illustrate, adesivi con immagini e slogan sono diventati una componente indispensabile non solo del discorso politico ma di una vita in cui ogni momento è una lotta. Di conseguenza, la stessa arte si è trasformata. Sulla spinta dei movimenti popolari, l’arte si è sempre più sviluppata nelle strade e, come in genere i movimenti sociali, si è femminilizzata.
Un esempio potente della rivoluzione che si è operata nell’arte di strada sono i graffiti dipinti sulle pareti di La Paz dalle componenti di Mujeres Creando, che ridefiniscono l’immaginario collettivo della città trasformando i suoi muri in un vasto tazebao, che critica le politiche del governo, sfida i codici morali consolidati, e mantiene in vita il senso di un’alternativa alla politica istituzionale[14].

In questo contesto, anche oggi è importante la presenza nei movimenti di artisti politicizzati, così come la collaborazione con attivisti ed educatori esterni, che possono, per esempio, fornire informazioni e approfondimenti sulle politiche governative che penalizzano la comunità. Ci sono tuttavia pericoli, in un contesto in cui la mercificazione di ogni aspetto della vita sta modificando anche le lotte sociali. Oggi si guarda anche alle lotte come a delle merci, con gli artisti in funzione di strumenti di gentrificazione. Ormai gli spazi in cui artisti ed educatori contribuiscono ai movimenti popolari sono costantemente minacciati da interessi commerciali, nonché dalle autorità e dalla polizia che temono qualsiasi forma di potere che viene dal basso.
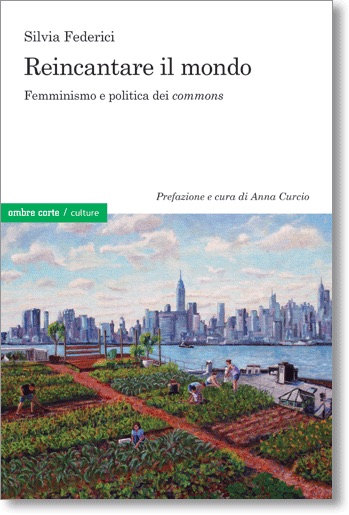 È importante ribadire dunque che artisti ed educatori non sono attori
neutri, né possono immaginare di essere i vettori di una particolare
creatività e conoscenza relativa alle lotte. Come suggeriscono gli
esempi indicati, le donne hanno dimostrato una grande capacità di
autonomia e di auto-organizzazione. Hanno anche dimostrato che è dalla
necessità che nasce l’invenzione di nuove attività e nuove relazioni. È quindi
più opportuno pensare alla lotta che le donne e i movimenti popolari
stanno facendo nei quartieri poveri in tutto il mondo come a una
escuelita[15], dove gli artisti, gli attivisti, gli educatori possono
imparare non solo a “de-professionalizzasi” ma a coltivare un diverso
tipo di creatività rispetto a quella solitamente associata
all’espressione artistica. Questa è la creatività che si
genera quando modifichiamo i nostri rapporti con gli altri, scoprendo
nel potere della cooperazione il coraggio di resistere alle forze che
opprimono la nostra vita.
È importante ribadire dunque che artisti ed educatori non sono attori
neutri, né possono immaginare di essere i vettori di una particolare
creatività e conoscenza relativa alle lotte. Come suggeriscono gli
esempi indicati, le donne hanno dimostrato una grande capacità di
autonomia e di auto-organizzazione. Hanno anche dimostrato che è dalla
necessità che nasce l’invenzione di nuove attività e nuove relazioni. È quindi
più opportuno pensare alla lotta che le donne e i movimenti popolari
stanno facendo nei quartieri poveri in tutto il mondo come a una
escuelita[15], dove gli artisti, gli attivisti, gli educatori possono
imparare non solo a “de-professionalizzasi” ma a coltivare un diverso
tipo di creatività rispetto a quella solitamente associata
all’espressione artistica. Questa è la creatività che si
genera quando modifichiamo i nostri rapporti con gli altri, scoprendo
nel potere della cooperazione il coraggio di resistere alle forze che
opprimono la nostra vita.
Articolo tratto da Reincantare il mondo. Femminismo e politica dei commons (ombre corte, con prefazione a cura di Anna Curcio), dove è apparso con il titolo “Produrre il comune nella città”.
Note
[1]*Commoning the City. From Survival to Resistance and Reclamation, in “The Journal of Design Strategies”, 9, 1, 2017.
Rodolfo Morales (8 maggio 1925 – 30 gennaio 2001) è un rinomato pittore messicano che ha rappresentato le donne come fondamento della vita sociale in Messico.
[2] Come ha scritto David Harvey citando il sociologo urbano Robert Park. Si veda David Harvey, Città ribelli. I movimenti urbani dalla Comune di Parigi a Occupy Wall Street, il Saggiatore, Milano 2013, pp. 21-22.
[3] Maria Mies e Veronika Bennhold-Thomsen, The Subsistence Perspective. Beyond The Globalized Economy, Zed Books, Londra 1999, p. 125-126.
[4] Mies e Bennhold-Thomsen, The Subsistence Perspective, cit., p. 127.
[5] Si veda Harvey, Città ribelli, cit., pp. 21-45.
[6] Si veda Silvia Federici, Il punto zero della rivoluzione. Lavoro domestico, riproduzione e lotta femminista, ombre corte, Verona 2014.
[7] Raúl Zibechi, Territories in Resistance. A Cartography of Latin American Social Movements, AK Press, Oakland CA 2012, pp. 236-237, 241, 261; Raúl Zibechi, Descolonizar el pensamiento crítico y las praticás emancipatorias, Ediciones desde abajo, Bogotá 2015.
[8] Si veda Fantu Cheru, The silent revolution and the weapons of the weak. Transformation and innovation from below, in Louise Amoore (a cura di), The Global Resistance Reader, Routledge, New York 2005, pp. 74-85.
[9] Jo Fisher, “The Kitchen Never Stopped”. Women’s self-help groups in Chile’s shanty towns, in Jo Fisher, Out of the Shadow. Women, Resistance and Politics in South America, Latin American Bureau, Londra 1993, pp. 16 ss.
[10] Natalia Quiroga Díaz e Verónica Gago, Los comunes en femenino. Cuerpo y poder ante la expropriación de las economías para la vida, in “Economía y Sociedad”, 19, 45, 30 giugno 2014.
[11] Mujeres Creando, Mujeres Grafiteando, Compaz, La Paz 2009.
[12] Maria Galindo, No Se Puede Descolonizar Sin Despatriarcalizar, in www.mujerescreando.org, 2013, http://www.mujerescreando.org/pag/prensa/2013/libro-nosepuededescolonizar.htm.
[13] Silvia Federici e R.J. Maccani, Interview with Pricilla Gonzalez, in Camille Barbagallo e Silvia Federici (a cura di), “Care Work” and the Commons, Phoneme Books, Nuova Delhi 2012.
[14] Mujeres Creando, Mujeres Grafiteando, cit.
[15] Zibechi, Descolonizar el pensamiento crítico, cit., pp. 161-170.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
Più di 500, 40, 30, 20, 10 anni dopo
ALLERTA ROSSA E CHIUSURA CARACOLES
BOICOTTA TURCHIA
Viva EZLN
Questo video è una libera interpretazione che vuole mettere in risalto l'importanza del Caffè Rebelde Zapatista, come principale fonte di sostentamento delle comunità indigene zapatiste e come bevanda prelibata, degustata da secoli in tutto il mondo. I suoni e i rumori che accompagnano l'osservatore in questa proiezione, sono stati scelti con l'intenzione di coinvolgervi completamente nell'esperienza visiva e trasportarvi direttamente all'interno della folta vegetazione che contraddistingue tutto il territorio del Chiapas, dove viene coltivato questo caffè.
La lucha sigue!


